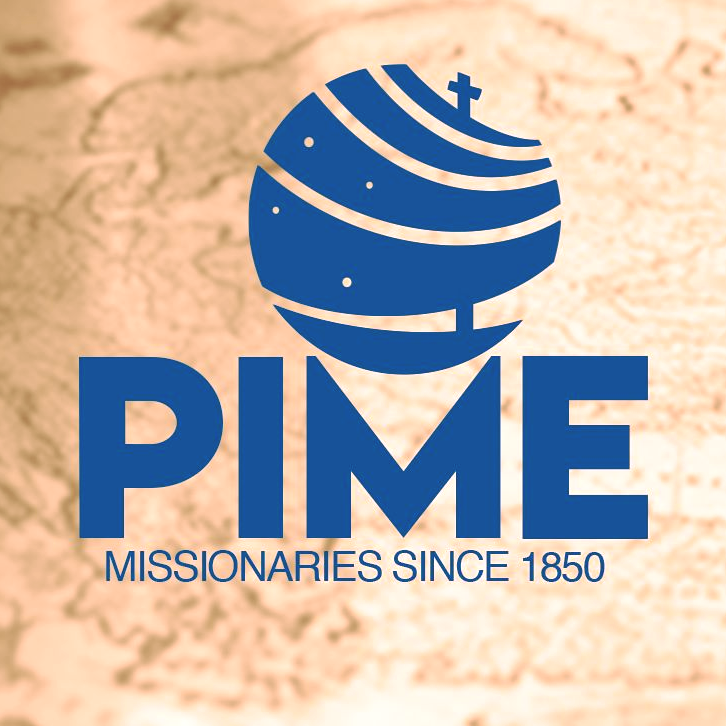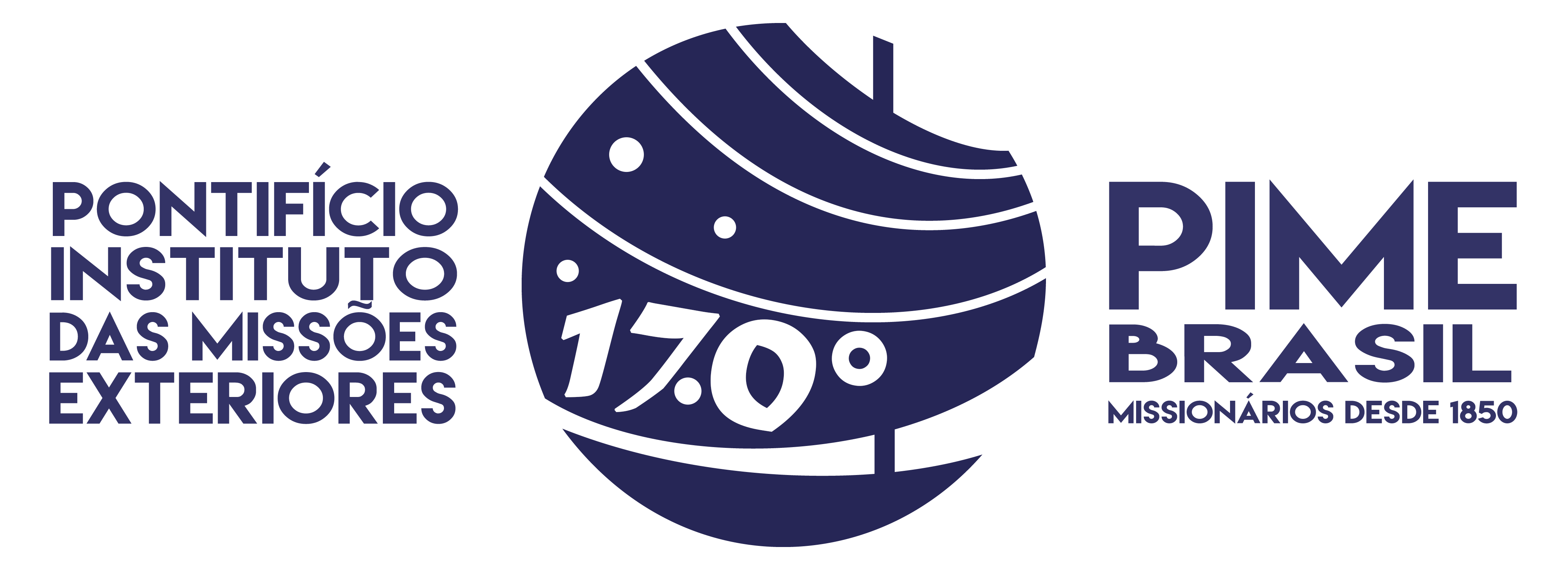Giovanni Paolo II e i rapporti con l'Ortodossia russa
I rapporti fra Chiesa Cattolica e Ortodossia Russa hanno subito in questi anni un arresto. Ma non tutto è perduto. In occasione della visita del Presidente Vladimir Putin a Giovanni Paolo II, pubblichiamo questa lucida analisi di un esperto.
Mosca (AsiaNews) - I cambiamenti storici avvenuti nel corso dei venticinque anni di pontificato di Giovanni Paolo II sono stati così profondi, da far pensare che sia passato ben più tempo dell'arco di una generazione umana. Uno dei più impressionanti è stato senz'altro il rovesciamento totale dello stile delle relazioni ecumeniche tra i cattolici e gli ortodossi, tornato a un livello di incomprensione e concorrenza simile a quello di almeno un secolo fa, prima che iniziassero i moderni tentativi di dialogo ecumenico.
Da più di cent'anni non risuonava nelle relazioni tra i "fratelli cristiani separati" la reciproca accusa di "proselitismo", di reciproca invadenza del proprio campo o "territorio canonico". Proprio per eliminare questa concorrenza, scandalosa soprattutto nei territori di missione, agli albori del '900 erano iniziati i primi timidi colloqui interconfessionali, prima tra le denominazioni protestanti, poi coinvolgendo ortodossi e cattolici. Il processo storico portò alla formazione di organismi oggi gloriosi come il Consiglio Mondiale delle Chiese e alla stagione del dialogo teologico e pastorale. La Chiesa Cattolica si inserì magistralmente in questo fervore con i pronunciamenti del Concilio Vaticano II, che divenne subito un punto di riferimento anche per gli altri cristiani, e in particolare per gli ortodossi. Proprio al Concilio sembrò avvenire quasi un miracolo: le delegazioni di osservatori ortodossi superarono i tentennamenti e parteciparono con passione, trascinate proprio dal gruppetto dei russi, che sembravano gli invitati meno probabili, e che invece precedettero anche i greci, mettendosi alla testa del processo di riavvicinamento tra l'Oriente e l'Occidente cristiano. Lungo il dell'intero pontificato di Giovanni Paolo II, il Patriarcato Ortodosso di Mosca poté vantare un rapporto specialissimo e fecondo con la Chiesa Cattolica, con un intenso e continuo scambio di delegazioni e molte testimonianze di reciproca accoglienza: in quegli anni, nelle poche chiese ortodosse aperte in Unione Sovietica, controllatissime dalla polizia comunista, i sacerdoti ortodossi dispensavano la comunione anche ai cattolici; la solidarietà diventava totale nel portare insieme la croce della persecuzione antireligiosa. La "Chiesa del silenzio", di cui lo stesso cardinal Wojtyla era figlio, era in realtà una Chiesa nuovamente unita, insieme ortodossa e cattolica, come nei primi secoli del cristianesimo.
Oggi tutto questo sembra cronaca lontana e sbiadita, più vicina al sogno romantico degli unionisti dell'Ottocento, che non alle prospettive apertesi con il Terzo Millennio. È difficile attribuire la responsabilità di questa strana e imprevedibile evoluzione a Giovanni Paolo II: egli ha sostenuto la causa ecumenica con ardore non inferiore a quello dei suoi immediati predecessori, anzi, ha guidato egli stesso momenti e passaggi di fraternità ecumenica e interreligiosa così avanzati da lasciare perplessi anche diversi ecclesiastici usciti dal Concilio. Basti pensare alle preghiere ecumeniche di Assisi: alla prima, il 27 ottobre 1986, partecipò una delegazione entusiasta di ortodossi russi, guidata dal metropolita Filarete di Kiev, allora il candidato più probabile alla successione dell'anziano Patriarca Pimen. Pochi mesi dopo, nel giugno 1988, alle celebrazioni del Millennio del Battesimo della Rus', in piena perestrojka gorbacioviana, si recò a Mosca una massiccia truppa di ben 10 cardinali cattolici, guidati dal Segretario di Stato Casaroli: sarebbe rimasta la delegazione cattolica più importante mai ricevuta in Russia, ma allora sembrava solo il gruppo degli apripista di una futura visita del Papa a Mosca, rimasta il sogno incompiuto di tutto il pontificato. Incoraggiante fu anche l'assise ecumenica europea di Basilea del 1989, co-presieduta dal cardinale di Milano Martini con il metropolita di Leningrado Alessio, che di lì a qualche settimana diventò poi il nuovo Patriarca di Mosca: sembrava uno dei più fraterni amici della Chiesa Cattolica, sarebbe diventato il più orgoglioso avversario del Papa nel campo interreligioso a livello mondiale.
La storia pare aver cospirato a rendere più arduo il cammino verso l'unità di quegli anni decisivi. Nelle incredibili settimane che portarono all'elezione di Giovanni Paolo II nel 1978, il principale protagonista del dialogo da parte degli ortodossi russi, il metropolita Nikodim di Leningrado (più giovane di Wojtyla di sette anni!) morì letteralmente tra le braccia del Papa Giovanni Paolo I, a sua volta così repentinamente scomparso. Non possiamo sapere cosa sarebbe accaduto se il Papa attuale avesse avuto come principale interlocutore questo campione dell'ecumenismo post-conciliare, che in privato amava celebrare la Messa latina in lingua russa e sapeva convincere i più arcigni generali sovietici a rilasciare i dissidenti religiosi, ma non si può non pensare che sia stato proprio uno di quegli appuntamenti scritti nel destino, che la storia fece sfiorare senza realizzarsi.
Un anno dopo quell'incontro mancato, il Papa si recò nella sua patria, per il primo storico pellegrinaggio in Polonia, che inaugurò la serie dei grandi viaggi che hanno in qualche modo cambiato la storia stessa della Chiesa. Nell'antica sede primaziale di Gniezno, Giovanni Paolo II ricordò l'importanza del contributo dei popoli dell'Europa orientale alla vita del continente e del mondo intero, a partire dalle comuni radici cristiane. L'imminente ingresso della Polonia e di altri paesi limitrofi nell'Unione Europea appare la realizzazione compiuta di quella profezia; l'effetto immediato delle parole del pontefice fu il sorgere del movimento operaio e cristiano che portò alla caduta del comunismo, nemico secolare della Chiesa e del cristianesimo. La reazione russa a quegli avvenimenti fu di incredulità e di disorientamento: ebbe inizio un decennio indimenticabile che portò al crollo di tutte le certezze del mondo comunista, fino al dissolversi stesso dell'impero e del sistema sovietico. Alla gratitudine degli uomini e delle donne, liberate dal giogo sociale e spirituale che pareva impossibile da spezzare, è succeduta col tempo anche il forte risentimento delle strutture del potere, che hanno finito per attribuire al Papa liberatore una volontà di dominio simile a quella che gli era stata sottratta. Hanno qui origine le accuse di invadenza e di prevaricazione, attribuite in modo onestamente spropositato e incongruente ai cattolici in Russia e Ucraina, che la Chiesa Ortodossa si è incaricata di ripetere con ossessiva insistenza dal 1990 in poi, in nome dell'autonomia e della "integrità spirituale" del popolo russo. Alla condivisione di un comune destino di sofferenza e fedeltà al Vangelo negli anni bui, l'ortodossia russa fece succedere un atteggiamento estremamente aggressivo e pregiudiziale, distorcendo ogni azione, dichiarazione o perfino intenzione del Papa e dei cattolici per affermare la propria distanza e superiorità morale.
Va detto che in più occasioni i cattolici hanno ingenuamente offerto il fianco a interpretazioni malevole. Una preoccupazione frettolosa e sproporzionata per la riapertura delle strutture ecclesiastiche, prima di una effettiva riaggregazione dei fedeli sparsi per il territorio russo, ha dato l'impressione di volersi accaparrare le anime negli anni confusi del post-comunismo. Una gestione fragile e contraddittoria del problema degli uniati in Ucraina ha esacerbato inutilmente gli animi. I missionari cattolici si sono fatti prendere la mano da sentimenti anche sinceri di zelo evangelizzatore. A volte tale zelo era condito da uno spirito di rivincita culturale ed etnica (soprattutto nei sacerdoti provenienti dalle ex-colonie); a volte da aspirazioni, grossolane seppur in buona fede, di effettuare sbrigative sintesi tra le tradizioni dell'Oriente bizantino e dell'Occidente latino, in particolare nei sacerdoti e laici dei paesi occidentali, in preda al trasporto romantico per una "Santa Russia" che in realtà da tempo non esisteva più.
Alcuni errori particolarmente goffi di comunicazione e di strategia da parte dei cattolici locali e di qualche struttura vaticana - hanno spinto all'estremo un clima di diffidenza e di ostilità, culminato addirittura nell'espulsione di un vescovo e di alcuni sacerdoti dal paese. In campo cattolico molti eminenti esponenti della cultura e della stessa gerarchia hanno talvolta ulteriormente acuito la dialettica cattolico-ortodossa, schierandosi apertamente contro le posizioni dei loro confratelli cattolici e del Papa stesso. In un contesto così polarizzato, è apparso piuttosto velleitario ogni tentativo di far ripartire il dialogo dalle trattative su una possibile visita del Papa in Russia, o in alternativa sul possibile incontro tra il Papa e il Patriarca in campo neutro. Tali tentativi hanno sortito esattamente l'effetto contrario, allontanando sempre più la reale possibilità di un tale incontro, e indebolendo ulteriormente la posizione dei cattolici all'interno del paese.
Ma il rapporto tra Giovanni Paolo II e la Russia non è stato un fallimento. Nonostante il chiaro insuccesso delle relazioni ecumeniche ai vertici, il cattolicesimo è oggi presente in Russia in modo significativo, non tanto nelle dimensioni numeriche (circa 300 parrocchie, frequentate realmente da circa 40-50mila fedeli su un insieme di mezzo milione di cattolici "virtuali"), ma nella sua espressione di testimonianza spirituale e culturale, come mai era avvenuto prima. Nella travagliata storia russa, infatti, la presenza dei cattolici era sempre confinata nei recinti delle minoranze etniche polacca, tedesca, lituana, o al più era sfruttata la capacità formativa degli ordini religiosi - soprattutto dei gesuiti - per educare i figli dei dignitari e dei nobili. Oggi invece esiste realmente, pur nella sua fragilità, un vero "cattolicesimo russo" a tutto campo, dalle parrocchie agli ordini religiosi, con proprie istituzioni culturali e caritative, capace di interloquire con la società e la popolazione, che può finalmente venire a contatto con l'esperienza viva e la grande tradizione della Chiesa Cattolica.
Mentre le gerarchie sono impegnate in una partita storica e politica, spesso condizionata da interessi assai lontani dall'annuncio del Vangelo, si rende possibile un incontro fecondo tra uomini e donne di ogni condizione sociale e culturale, sacerdoti e monaci, intellettuali e famiglie, soprattutto nelle grandi città, ma anche nei villaggi sperduti della "Russia profonda". Al livello della gente comune di Russia, il prestigio di Giovanni Paolo II non è inferiore a quello riconosciutogli in tutto il mondo, nonostante che la propaganda nazionalista lo dipinga come ideologo principe dell'Occidente corrotto.
L'Ortodossia ha conquistato a sua volta grandi favori nel mondo occidentale, soprattutto nei paesi cattolici, imponendosi come "polmone orientale" quanto mai necessario alla rinascita religiosa della stessa civiltà occidentale. Il Papa slavo ha saputo valorizzare e diffondere l'ideale dell'integrazione tra cristianesimo latino e bizantino, esponendolo e proponendolo alla Chiesa intera in numerose encicliche (pensiamo alla "Slavorum apostoli" sui santi Cirillo e Metodio, proclamati "compatroni d'Europa"), lettere, interventi e viaggi anche nello stesso mondo ortodosso, come quelli recenti e particolarmente significativi in Romania, Ucraina, Bulgaria e Grecia.
Il sogno non realizzato del viaggio in Russia rimane così un ultimo compito e un'ultima profezia dello straordinario pontificato di Giovanni Paolo II, chiamando la Chiesa intera alla testimonianza di un'unità vitale e profonda, liberata dai complessi e dalle contraddizioni residue del secolo peggiore della storia della Chiesa, quello passato, per aprirsi con fiducia all'azione dello Spirito nel nuovo millennio, a "prendere il largo" in un mondo che non può fare a meno della presenza di Cristo.
21/02/2018 08:46
20/02/2018 08:51
19/02/2018 08:34